50ª EDIZIONE SETTIMANA SOCIALE.
Non basta mettere più soldi nel Ssn; occorre “costruire un sistema che funzioni e garantisca a tutti equità nell’accesso alle cure”. Alla vigilia dell’apertura dell’appuntamento di Trieste, l’analisi a 360° del direttore della Pastorale della salute della Cei. L’autonomia, afferma, è un’arma a doppio taglio: “Può essere un’opportunità, ma il governo centrale deve intervenire laddove non ci sono le capacità e la forza di raggiungere il minimo indispensabile per garantire cure di qualità ai cittadini”.
Salute: curare i diritti di tutti è il tema dell’incontro tenutosi il 4 luglio a Trieste (Piazza Ponterosso – ore 17:30), nell’ambito delle “Piazze della democrazia” all’interno della 50ma Settimana sociale. Moderati da Mario Viglietti, sono intervenuti Silvio Brusaferro, Gilberto Turati, Silvia Landra. Come raggiungere l’obiettivo racchiuso nel titolo? “Costruendo un sistema in grado di garantire equità a tutti i cittadini”, risponde don Massimo Angelelli, direttore dell’Ufficio nazionale per la pastorale della salute della Cei.
Don Angelelli, perché portare il tema della sanità e del diritto alla cura alla Settimana sociale?
Perché si sta sviluppando una tendenza pericolosa. Prima del Covid vivevamo una situazione complessa, ma in qualche modo stabile. Il Covid ha messo in crisi una serie di sistemi, non tanto il Ssn in sé, quanto la sua dimensione organizzativa con la conseguenza che questo servizio “universalistico” – ecco dove si colloca il diritto alla tutela della salute – lo è sempre meno. Per un combinato disposto organizzativo-gestionale, le persone che vogliono curarsi non ricevono risposte in tempi accettabili dal Ssn e devono necessariamente rivolgersi al privato. Nel 2022 abbiamo sforato i 40 miliardi di out of pocket, a fronte di 4 milioni e mezzo di italiani che non si curano più perché non ne hanno la possibilità.
Stiamo scivolando di fatto fuori dal sistema universalistico, fuori dal dettato costituzionale, stiamo modificando strutturalmente il Ssn e questo non è accettabile. I recenti provvedimenti contro le liste di attesa – tra cui l’innalzamento del tetto di spesa con la prospettiva di eliminarlo dal 1° gennaio 2025, e la riduzione del prelievo fiscale sugli straordinari – basteranno?
Assolutamente no. Sono interventi importanti ma del tutto insufficienti. Il finanziamento del servizio sanitario è un tema grave, ma sussistono problemi strutturali che richiedono un ripensamento di tutto l’impianto.
In concreto, che cosa bisognerebbe fare?
Principalmente due interventi. Questo è un mestiere in cui persone curano persone, ma il Pnrr ha privilegiato essenzialmente strutture e strumenti tecnologici. Per fare bene sanità servono professionisti in grado di operare in maniera specialistica e qualificata, ma non devono essere sottoposti a carichi e dinamiche insostenibili perché lo stress lavoro-correlato porta all’errore. Non si tratta solo di assumere più personale ma di rendere attrattiva la professione medica e infermieristica valorizzando gli operatori: oggi rimangono posti vuoti nelle università e nelle scuole di specializzazione. Non possiamo immaginare la medicina senza anestesisti, medici di emergenza urgenza, infermieri e medici di base. Intanto i Pronto soccorso scoppiano e i pazienti non vengono curati come dovrebbero esserlo. Occorre aumentare le risorse umane e ridistribuirle in modo capillare sul territorio, con il coinvolgimento dei medici di base.
Il secondo intervento?
Serve un ripensamento strutturale, una nuova riforma. Quella del ’78 è datata: il sistema dell’accentramento degli ospedali per acuti non ha funzionato perché ha spogliato il territorio. Occorre creare una reale rete di continuità tra il momento dell’acuzie e la presa in carico successiva sul territorio, oggi assente tranne in qualche regione del nord, in particolare il Veneto. Preoccupano i numeri del pendolarismo sanitario di chi, non trovando sul proprio territorio le cure necessarie, è costretto a spostarsi, anche di 600 km, con enormi costi economici, fisici e psicologici. Su questo stiamo pensando ad un progetto.
Di che cosa si tratta?
Insieme all’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma stiamo immaginando di creare dei punti di riferimento nelle regioni del centro-sud affinché i piccoli pazienti (e le loro famiglie) possano trovare, una volta superata l’acuzie e la prima fase di riabilitazione, centri di riferimento specialistici territoriali per non essere costretti a dover viaggiare ogni volta fino a Roma. Stiamo riflettendo dove individuare questi centri sotto l’egida e la supervisione scientifica del Bambino Gesù. Vorremmo avvicinare la cura alle esigenze delle persone. Più in generale, occorre rafforzare – o costruire laddove non esiste – questa rete sui territori.
Nei giorni scorsi Crea Sanità ha reso noto che a 26 milioni di italiani, tutti residenti al sud, non vengono garantiti buoni standard di cure e tutela della salute.
L’assegnazione alle regioni della competenza in sanità ha portato di fatto, a 21 sanità regionali creando importanti divari. Se la cosiddetta autonomia differenziata – ormai divenuta legge – costituisce una grande opportunità per colmarli, può comportare anche il rischio di ampliarli ulteriormente. Per questo, chiedo alle strutture sanitarie cattoliche e di ispirazione cristiana di fare, come privato non profit, quello che lo Stato non riesce a fare, ossia creare reti di sostegno sul territorio. Spero che questo consolidamento di collaborazioni tra strutture sanitarie cattoliche diventi un meccanismo virtuoso. Così come nell’ambito della ricerca stiamo promuovendo collaboratori tra gli Irccs di matrice cattolica (circa una dozzina, tra cui Policlinico Gemelli, Gemelli Isola S. Giovanni Calibita e Fondazione Don Gnocchi. ndr) in modo che possano sostenersi ed aumentare l’efficacia della ricerca.
Del resto, la sanità “religiosa” è una parte importante del sistema sanitario nazionale.
Tra Aris (ospedalità) e Uneba (socio-sanitario) abbiamo calcolato circa 1.370 strutture con 115mila posti letto e oltre 150mila risorse umane. Tutti devono imparare a lavorare meglio in rete, con l’umiltà di confrontarsi con gli altri e di rendersi conto che le cose insieme si fanno meglio. La rete porta un’economia di scala che altrimenti non si potrebbe realizzare, ma non è questo l’obiettivo primario che consiste piuttosto nella possibilità di massimizzare l’effetto testimoniante di quello che si fa. E’ un problema di identità, perché non facciamo sanità per business ma per assicurare qualità di cure anche a chi non se la può permettere. Se la rete sanitaria e sociosanitaria cattolica non recupera la propria identità, non è efficace; e se non è efficace è inutile.
La relazione al centro della cura?
Assolutamente sì, ed è ciò che dobbiamo testimoniare perché ci differenzia dal resto del sistema.
Tornando all’autonomia differenziata: opportunità o rischio di ampliare le disuguaglianze sferrando il colpo di grazia alla sanità del sud?
L’enorme disparità è sotto gli occhi di tutti. Dare più autonomia alle regioni può essere un’opportunità, per quelle in maggiore difficoltà, di recuperare, ma non ce la faranno da sole; servono collaborazione e incrocio di competenze perché le regioni del sud hanno potenzialità che però, per diversi motivi, non riescono a sfruttare. La domanda di fondo è: autonomia significa opportunità di fare meglio? Voglio sperare sia così.
È una questione di risorse?
E’ soprattutto una questione di organizzazione, di management, di visione, perché le risorse vengono allocate in maniera equa in base alle dimensioni e alle situazioni delle diverse regioni. Il tema di fondo è come il governo centrale possa migliorare l’equità, senza puntare solo all’uguaglianza.
Uguaglianza significa: ogni cittadino un tot di risorse; equità significa: una regione in piano di rientro con evidenti difficoltà a gestire la propria organizzazione deve essere aiutata. Nell’ambito dell’autonomia, lo Stato deve svolgere un ruolo di accompagnamento delle regioni che da sole non sono riuscite a raggiungere gli obiettivi richiesti, altrimenti gli effetti saranno disastrosi.
Oltre ai Lea, la sfida è quella dei Lep…
Sì. Lo Stato traccerà una linea. Chi rimane al di sotto lo abbandoniamo o lo mettiamo in condizione di recuperare? Al governo centrale il compito di intervenire laddove non ci sono le capacità e la forza di raggiungere il minimo indispensabile per garantire la qualità delle cure ai cittadini. Occorre creare un modello di equilibrio in cui l’autonomia consenta di fare meglio ma, al tempo stesso, laddove non ci sono le condizioni, lo Stato intervenga perché è suo compito garantire l’equità dei cittadini in forza dell’art. 32 della Costituzione. Punto di partenza è l’uguaglianza dei diritti; punto d’arrivo l’equità attraverso un maggiore supporto a chi è più svantaggiato.
[Fonte: Agenzia SIR – Ufficio Nazionale per la Pastorale della Salute della CEI]





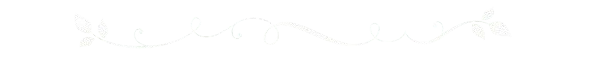
Scrivi un commento