La ricerca su “Gli italiani, la fede e la Chiesa”. Conversazione con il presidente della Conferenza episcopale italiana, cardinale Matteo Zuppi
Il cardinale Matteo Zuppi accetta di dialogare con i media vaticani partendo dai risultati della recente ricerca “Italiani, fede e Chiesa” effettuata dal Censis che descrive lo stato dell’arte della religione cattolica nel Bel Paese. Il dato principale è che sette italiani su dieci si sono dichiarati credenti però le sfumature all’interno di questi numeri sono tante e il colore prevalente è il grigio. Di una “zona grigia” parla la relazione curata da Giulio De Rita, una zona in cui convivono tanti elementi anche contraddittori, come ad esempio il fatto che dal punto di vista “prestazionale”, della pratica religiosa, i cattolici sono in verità in minoranza perché gli italiani frequentano poco la Chiesa, «le funzioni, i riti, conoscono poco la scrittura e la cultura cattolica in generale e seguono poco le vicende ecclesiastiche, verso le quali hanno anche una certa diffidenza, che però quasi mai si traduce in ostilità». Ma, dall’altra parte si può dire che i cattolici sono una maggioranza se il riflettore lo puntiamo sul fatto che permane nella società un desiderio di “riconoscersi”, un voler continuare «ad appartenere a una comunità, magari senza frequentarla con continuità, senza rispettarne le regole e nutrendo anche una certa diffidenza sul modo in cui viene gestita da chi ha incarichi di responsabilità».
Quindi dipende un po’ da come la vogliamo vedere, come la vede il presidente della Conferenza episcopale italiana?
Questo dato che ricaviamo dalla ricerca del Censis ci aiuta a una comprensione più oggettiva perché ci offre alcune chiavi di lettura. In particolare colpisce proprio la considerazione di questa zona grigia; il grigio effettivamente, come è noto, si può interpretare in vari in vari modi. Non vogliamo interpretarlo in maniera positiva per tirarci su, per dirci che “in fondo non siamo tanto male”. Credo che questo sarebbe un approccio sbagliato, nel senso che alla Chiesa interessa sempre affrontare i problemi, non eluderli o far finta che non ci siano, cadendo nella tentazione di edulcorare. Al contrario la Chiesa entra nella storia e nelle sue contraddizioni, nelle difficoltà che sono peraltro evidenti e che tanto ci interrogano. E questo è proprio il senso anche del cammino sinodale. Perché la terapia di Papa Francesco di farci “uscire” è basata sull’ascolto. Una terapia, per inciso, di cui ancora c’è bisogno: necessitiamo infatti ancora di qualche altro “trattamento” perché in realtà facciamo tutti sempre una grande fatica. E non è sufficiente soltanto mettersi in mezzo agli altri perché qualche volta abbiamo ancora degli schemi, direi delle “toponomastiche”, dei riferimenti e dei giudizi che partono in automatico e finiscono per sovrapporsi alla realtà, chiuderla in schemi ideologici e finiamo per non lasciarci più interrogare da essa. La realtà questo fa, ci interroga. Nel cammino sinodale la Chiesa italiana per due anni ha scelto la via dell’ascolto proprio per rimetterci a capire e anche per affinare il linguaggio. Qualcuno non è d’accordo, qualcuno dice che «noi (Chiesa) dobbiamo insegnare e invece ora ci facciamo insegnare» ma questo è sbagliato, perché soffoca il dialogo. E il dialogo non significa mettere in soffitta o relativizzare le proprie convinzioni, ma significa farsi ferire dal mondo proprio per poter parlare e comunicare in maniera efficace l’annuncio del Signore Gesù, il Figlio di Dio, che è morto ed è risorto. In questo dialogo dobbiamo fare i conti con il “grigio”, con onestà, senza vederlo per forza in positivo ma nemmeno in maniera negativa. La chiave che ci ha dato la ricerca è questa zona grigia che è un misto di legami e di diffidenza, ma allo stesso tempo di appartenenza, di stima ma anche di critica. Tutto dentro una cultura che può diventare ancora più fluida, diciamo gassosa, dove tutto significa niente. Questo è il grande rischio che però dobbiamo correre stando dentro questa zona che dobbiamo cercare di capire, accettando la realtà così com’è e provando a dare le risposte che essa richiede.
Questa zona grigia, emerge dalla ricerca, «non è una nuova declinazione della società liquida ma un riposizionamento individuale». Il dato che emerge alla fine è che l’individualismo, caratteristico della nostra società contemporanea, è diventato tipico anche del mondo religioso, e forse si dovrebbe parlare non tanto di religiosità, di religione, ma di spiritualità. La sinodalità può essere la risposta a questo individualismo?
Sicuramente. La sinodalità non è applicare alcuni vecchi schemi rinnovati con qualche aggiornamento ma sta proprio nell’interrogarsi e nel trovare le risposte, le risposte più adeguate. Il grigio di cui parliamo in realtà nasconde anche una domanda e per questo è importante anche per noi; una domanda a volte generica, non chiara, che possiamo bollare come se avesse poco a che vedere con la fede, ma che a volte si rivela come una grande domanda di spiritualità che dobbiamo ascoltare, incontrare, che è nascosta nel cuore di ognuno e apre alle grandi domande della vita.
Senza dubbio oggi l’individualismo è diffuso in tutte le appartenenze, disgregandole. Da questo punto di vista la Chiesa per tanti motivi è ancora un’appartenenza in cui forse c’è oggi una modalità diversa, se vogliamo meno forte, meno militante, in cui i comportamenti personali sono spesso slegati dagli insegnamenti della Chiesa ma che allo stesso tempo rivela di essere un grande legame. Da qui si può provare a ripartire e riprendere dei fili perché si possa ricostruire il “noi”. Anche questo vuol dire la sinodalità: appartenenza e il camminare insieme agli altri.
Perché forse la solitudine è l’altro nome dell’individualismo…
La solitudine è il frutto dell’individualismo. È qualcosa di terribile, che porta allo scarto, per usare il vocabolario di Papa Francesco. L’individualismo si basa sulla prestazione, sul protagonismo, l’esibizione di sé e infine sul consumo, il consumo immediato. Debbo verificare le mie capacità, debbo possedere per esistere. Su questa base si è aggiunta, negli ultimi anni, l’esplosione del digitale, che porta con sé grandi possibilità ma anche grandi rischi, perché la vita può “rinchiudersi” dentro il digitale e poi ovviamente si scontra con il reale. Dobbiamo entrare in tutta questa realtà e credo che il cammino sinodale sia la strada giusta, qualche volta con qualche fatica ma ci fa, per esempio, accorgere di una domanda che esiste, ci fa avvicinare di nuovo a tante richieste che se rimanessimo in una lettura superficiale e approssimativa della realtà, una lettura un po’ giudicante, non capiremmo. Mentre invece riaprendo le condizioni di un dialogo, di un incontro, di una possibile relazione ecco che entriamo dentro questo “grigio” e forse sappiamo di nuovo capire meglio la realtà e dare le tante risposte a quella domanda che c’è; e non a ciò che pensiamo noi, ma a quella domanda che è nel cuore delle persone.
Papa Francesco in uno dei suoi primissimi interventi nel marzo del 2013 disse che la Chiesa «non è una ong pietosa», che non fa filantropia, non è un’organizzazione umanitaria. Nella ricerca risulta che una Chiesa “solo orizzontale” non intercetta chi è ubriaco di individualismo, perché a costoro non basta sostituire l’io con un noi, hanno bisogno di un oltre, hanno bisogno di andare oltre l’io. E la Chiesa, ricorda il Censis, è sempre stata forte quando ha indicato un “oltre” al popolo dei fedeli.
È un interessante pungolo, questo. Non va infatti fraintesa questa Chiesa sinodale con una Chiesa meramente orizzontale, solo “sociale”. Magari c’è qualcuno che vuole fraintendere, o chi vuole leggere sempre in negativo o prendere soltanto un pezzetto e non tutto il processo, e non ne capisce così l’interezza. O non vuole capire. È chiaro invece che la sinodalità cammina sempre tenendo insieme la collegialità con il primato. La dimensione orizzontale, indispensabile, non solo non mette in discussione quella verticale, ma anzi le dà pienezza e senso, perché la fa capire attraverso il coinvolgimento di tutti i battezzati con la dimensione comunitaria. La Chiesa non è una ong, non può essere una ong perché tradirebbe se stessa. Poi che ci possa essere la tentazione di questo è chiaro, così come ci può essere la tentazione contraria, di diventare una specie di tranquillante spirituale e finisci per vivere in un mondo tutto individualizzato in cui ogni tanto prendi qualcosa di spirituale, tutto ritagliato su te stesso e pensi così di essere a posto. Ovviamente non va bene nessuna delle due opzioni. È chiaro che il servizio ai poveri non è fare qualcosa per i poveri ma è la risposta alla parola di Gesù «ogni cosa che avete fatto a uno di questi miei fratelli più piccoli l’avete fatta a me». È questa la motivazione che spinge all’azione, che deve portare come dice il Papa, a “incarnare” questa vocazione, a toccare la fraternità, a mangiare insieme al fratello più fragile, a dare il posto a chi non ha casa, nella mia casa, a stare con lui, guardandolo negli occhi… altrimenti si vive in una sola dimensione che diventa spiritualismo, una deformazione dello spirituale. Questa non è e non potrà mai essere filantropia. Se ascoltiamo il Vangelo, e se lo viviamo, si scopre quella dimensione verticale che è la domanda spirituale, la domanda di senso, di futuro. È la domanda di quei greci che nel Vangelo volevano vedere Gesù, una domanda a cui noi dobbiamo dare una risposta viva, incarnata, cercando e trovando Gesù di Nazareth, non un’entità generica che forse può spaventare di meno ma in cui non c’è la bellezza di un volto, di un nome, di una storia, di un tu, di un altro con cui misurarsi e con cui stringere relazione. La Chiesa non può diventare un grande consultorio perché è molto di più.
Il 66% degli italiani secondo questa ricerca dichiara di pregare o comunque di rivolgersi a Dio o un’altra entità superiore. Addirittura questo numero riguarda anche i non credenti. La ricerca osserva che c’è una forte dimensione emozionale, intimista della preghiera perché la dimensione comunitaria, istituzionale è vista con sospetto. Quando tanti anni fa feci la cresima, nell’omelia il vescovo, il cardinale Canestri, disse che non esiste un cristiano privato. A distanza di quasi 50 anni da quell’episodio, le parole di Canestri ci dicono qualche cosa rispetto a questa torsione della società nell’intimismo e nelle emozionalità.
Senz’altro. Quelle parole dicono qualcosa di molto evangelico. Attenzione: dire che la fede non è un fatto privato non significa assolutamente che non sia personale nel senso più profondo del termine. La dimensione della scelta individuale, della coscienza individuale e dell’appartenenza non sono mai opposte ma anzi sono complementari. Guai se non ci fosse l’una e l’altra, altrimenti diventa appunto intimismo. Essere cattolici è un fatto ad un tempo molto personale e molto pubblico. Del resto questo era un vecchio dibattito che negli anni ’70 appassionava molti in un periodo in cui il privato si dissolveva nel pubblico perché tutto doveva essere pubblico; poi ha stravinto il privato che nutrito, direi “dopato” dal consumismo, ha fatto diventare tutto individualizzato. Qualcuno diceva di credere nella felicità di tutti, ma poi ci siamo buttati sulla felicità individuale e lì siamo rimasti e ci siamo dimenticati. Ma in fondo lo sappiamo: la felicità ci lega agli altri, nessuno può essere contento da solo perché è siamo “costruiti” così. Le Beatitudini non sono mai un fatto privato perché ci uniscono agli altri, sono qualcosa che viviamo insieme agli altri. Attenzione quindi a questa deriva intimista, emozionale, di chiusura nella propria dimensione psicologica, interiore.
Poche settimane fa il Papa ha pubblicato un’enciclica, la Dilexit nos, dedicata al Sacro Cuore di Gesù e più in generale alla dimensione del cuore. Sembra che il Papa ci dica che in un’epoca di grande emozionalità e intimismo il rischio non è che ci sia troppo cuore, ma troppo poco. È un bene prezioso quanto fragile il cuore, va “maneggiato” con cura, e di un cuore puro e forte il mondo di oggi, segnato dal freddo cinismo e dall’aggressività, ha estremo bisogno.
Assolutamente sì, per me infatti non c’è troppo cuore in circolazione oggi. Una riduzione di tipo devozionale vuol dire in realtà restare sempre in superficie. Quindi c’è bisogno di più cuore perché ce n’è poco e ci stiamo anche abituando a un mondo delle relazioni senza cuore, relazioni molto superficiali, schiacciate sull’apparenza, virtuali, digitali, compulsive, che non scendono nella profondità, nella ricchezza dell’interiorità che è il cuore. La Dilexit nos invece ci ricorda una grandissima verità, che il cuore trova se stesso quando trova l’altro cuore, quando si incontra con l’altro cuore. E chi ci dà cuore è il cuore di Gesù che appunto ci fa trovare il nostro cuore, il mio cuore, il cuore degli altri. Non c’entra quindi l’emozione, le pulsioni se poi non fanno trovare l’altro e quindi anche me stesso in quell’incontro. Il problema è che l’individualismo fa male all’individuo e che la prima vittima dell’egocentrismo è l’ego.
La ricerca si concentra sul tema della vita oltre la morte, forse questo è l’oltre più essenziale. A questa vita gli italiani ci credono ancora, però anche qui in modo “grigio”, in maniera un po’ vaga e a volte anche contraddittoria: credono alla vita oltre la morte ma non il giudizio, al peso dei peccati, al dovere di comportarsi bene qui sulla terra. Mi viene in mente una battuta di un suo predecessore, cardinale di Bologna, Giacomo Biffi che diceva: «Forse si è perso il senso del peccato, ma è molto vivo il senso del peccato altrui». Come ci auto-assolviamo così siamo pronti a condannare gli altri, avviluppandoci in una spirale fatta di moralismo che è un po’ un surrogato della morale, quasi la sua degenerazione ideologica della religione.
Tanti spunti. La prima cosa che mi viene da dire è che oggi il criterio di giudizio sono io. L’individualismo porta questa deformazione. Sono talmente egocentrico che non ho preso in considerazione che qualcuno potesse rimanere male del mio comportamento perché il criterio sono sempre io. Il peccato è anche questo, non capire le conseguenze dei propri atteggiamenti, non rendersene conto. In realtà abbiamo un enorme bisogno di giudizio e poi finiamo per raccontarlo nelle infinite interpretazioni o appunto in quel moralismo. Dio invece non è moralista, ma è molto morale. Dio giudica, certo che giudica, altrimenti ti lascerebbe solo, entrando magari in quel intimismo ma diventando giusto un grande “stabilizzatore d’umore”, uno che mi deve far stare tranquillo e basta. Ma non è così: c’è un giudizio e un giudizio sempre sull’amore, peraltro. Quindi il giudizio di Dio è sempre sull’amore. Come impariamo infatti ad amare? Quello di Dio è inoltre sempre un giudizio unito alla misericordia, che trova la sua pienezza nella misericordia. Il moralismo; Biffi lo diceva appunto con la sua nota arguzia e ci ricorda il passo evangelico della pagliuzza e la trave. Quella di oggi è un’epoca segnata da un falso rispetto per cui l’importante è che l’altro non mi tocchi ed io non tocchi lui perché sono affari suoi. Dove va a finire l’aiutarci a vicenda? Se vedo un mio fratello che si fa del male devo trovare il modo per aiutarlo, per fargli accorgersi che si fa del male. Il rispetto è fondamentale, ma è l’amore che rende pieno il rispetto. Il mondo terribile dei moralismi oscilla tra la spietatezza e un permissivismo in cui l’importante che è ognuno resti nella propria isola. E così siamo molto più esposti alla logica del male. Dobbiamo invece tutti capire che il giudizio di Dio è sull’amore e nell’amore e questo è bellissimo e liberante mentre il giudizio del moralista ti inchioda e ti condanna. Con il suo giudizio Dio ti libera e ti aiuta a rientrare in te stesso e a essere padrone di te stesso, cosa che non sei con il moralismo o facendo di te la tua regola.
Il Papa ha parlato del giudizio di Dio riferendosi ai 1000 giorni di guerra in Ucraina, perché “il Signore chiederà conto di ogni lacrima versata”. Nella famosa Statio Orbis del 27 marzo 2020, in pieno Covid, il Papa aveva chiamato quello come “tempo del giudizio”: «Non è il tempo del tuo giudizio, ma del nostro giudizio: il tempo di scegliere che cosa conta e che cosa passa, di separare ciò che è necessario da ciò che non lo è». Siamo usciti da quella prova e viene da chiedersi se quella crisi è stata un’occasione sprecata. Ora stiamo vivendo altre prove terribili come la guerra. Forse vogliamo evitare Dio e il suo giudizio?
Il giudizio di Dio non è quello di un professore un po’ esigente, ma di un padre che ci aiuta a vedere, a essere conseguenti nelle azioni, a renderci conto, a capire. Uno degli esempi più chiari è quello delle omissioni. Spesso diciamo: ma io che ho fatto di male? Appunto, non hai fatto niente. Quindi in realtà il non far niente è far male. L’indifferenza fa male, quando qualcuno è indifferente verso di noi ci rendiamo conto che l’indifferenza fa male. Quando qualcuno non viene salutato, quando gli altri non si fermano, non ti aiutano, ti guardano ma passano dall’altra parte e tu magari sei mezzo morto. Lo sappiamo tutti, è un’esperienza che viviamo tutti. La guerra, è come una pandemia perchè è “mondiale”, in questo senso tutte le guerre potremmo dire sono tante pandemie che riguardano tutti noi. Ciò che abbiamo con difficoltà capito nella durissima vicenda del Covid e che non dobbiamo dimenticare è che non è stato un problema di qualche regione della Cina ma che riguarda tutti. E la guerra è lo stesso. Tutto questo ci provoca e ci chiede di farci inquietare, di interrogarci perché è come una pandemia: il rischio è anche soggettivo e personale, non c’è nessuno che può dire “io sto in un’altra barca”, la barca è una sola anche nella pandemia della guerra.
Fra un mese inizierà il Giubileo della speranza in questa Italia che vive come tutto l’Occidente in questa zona grigia, nel senso che forse ha nostalgia di quei legami che si sono spezzati, ma fa fatica a riconnettersi, perché vive appunto in questa deriva individualista. Cosa può rappresentare allora l’apertura della Porta Santa?
Alla luce di tutto quello che abbiamo detto capiamo ancora di più che la Provvidenza ci dona questo Giubileo che ha nel suo cuore proprio il desiderio di trovare la speranza. Il Giubileo della speranza è il segno di una scelta rivolta al futuro. Ci ricorda e ci invita ad essere tutti “pellegrini di speranza” in un mondo che al contrario fa disperare, che sembra rendere impossibile il futuro. La speranza è questo entrare nella storia, guardare negli occhi i problemi e affrontare il male. Nel segno tipico del Giubileo: riconciliazione con se stessi e grande riconciliazione nel mondo, appunto nella speranza dell’annuncio del Signore Gesù che nelle nelle pandemie continua a indicarci la via della salvezza. Sperare ha senso proprio quando la situazione sembra disperata, quando non si vede e quando tutto è buio, ma è nel buio che crediamo alla luce. Il Giubileo è una grande accensione di questa luce, è una porta che si apre, un futuro che entra nel presente e che ci aiuta appunto a pagare il prezzo della speranza, perché la speranza non è a basso costo, non è un supermercato dove mi prendo quello che mi serve. La speranza ti coinvolge, ti cambia, e questo ha un costo, ma sai che così facendo si costruisce qualcosa che avrà un frutto e apre il futuro.
Questa è la bellezza, la grandezza del Giubileo.
[Fonte: L’Osservatore Romano]






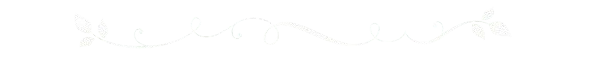
Scrivi un commento