La Quaresima è il periodo di quaranta giorni che prepara alla celebrazione della Pasqua. Inizia, nel Rito Romano, con il Mercoledì delle Ceneri, e, nel Rito Ambrosiano, con la domenica successiva. Termina, per entrambi i riti, alla messa inter vesperas in Cena Domini del Giovedì Santo, esclusa, con la quale inizia il sacro Triduo Pasquale.
I primi accenni diretti a un periodo pre-pasquale risalgono al principio del IV secolo in Oriente e alla fine dello stesso in Occidente. Una prassi penitenziale preparatoria alla Pasqua col digiuno, però, aveva cominciato ad affermarsi fin dalla metà del II secolo. In ogni caso alla fine del IV secolo la struttura della Quaresima è quella dei quaranta giorni; visti alla luce del simbolismo biblico essi acquisiscono un valore salvifico–redentivo, per cui vengono chiamati Sacramentum.
L’etimologia latina quadragesima dies sottolinea il quarantesimo giorno di preparazione in vista della principale festa dell’intero anno liturgico, che è appunto la Pasqua della Resurrezione del Signore.
Caratteristiche liturgiche
Nelle Messe di Quaresima si omette il Gloria.
Non si canta nemmeno l’Alleluia, né nella liturgia della Parola della Messa, nella quale è sostituito da un’acclamazione di lode a Cristo, né nella Liturgia delle Ore, nella quale semplicemente si omette.
Le memorie dei Santi non vengono celebrate durante la Quaresima.
Il colore liturgico è il viola per il Rito Romano.
Non si possono usare i fiori per ornare l’altare.
L’organo e gli altri strumenti musicali possono essere utilizzati esclusivamente per accompagnare i canti.
Storia
Allo sviluppo della Quaresima contribuirono le esigenze del catecumenato, con la preparazione immediata al Battesimo, a celebrarsi nella solenne Vigilia Pasquale: per i catecumeni la Quaresima era un’opportunità di speciale catechesi oltre che di preghiera e rinnovamento spirituale.
La quaresima era legata anche alla disciplina penitenziale, con la riconciliazione dei peccatori che avveniva nella mattina del Giovedì Santo: per i penitenti la quaresima era un periodo di lotta contro il male che doveva precedere l’assoluzione sacramentale.
Le tappe della progressiva evoluzione della Quaresima possono essere delineate come segue.
Il digiuno infrapasquale del Venerdì e del Sabato Santo
La Didaché prescrive un digiuno prima del Battesimo, da effettuarsi da parte del battezzando, del ministro e da “altri che sono in grado di farlo”. Si auspica cioè che i membri della comunità digiunino con coloro che stanno per essere battezzati. Specifica inoltre che il digiuno del battezzando duri “uno o due giorni“.
La Tradizione Apostolica (217) di Ippolito di Roma chiede anch’essa il digiuno “il Venerdì” per coloro che si preparano a ricevere il Battesimo.
Verosimilmente si tratta, in entrambi i casi, del Battesimo amministrato nella Veglia Pasquale, ma non è possibile affermarlo con certezza.
La Didaché parla anche di un digiuno praticato tutti i mercoledì (“quarto giorno”) e i giovedì (“giorno della preparazione”) dell’anno.
Il significato di questi digiuni non è ascetico, ma di illuminazione.
La preparazione di una settimana
Abbiamo testimonianze del fatto che nel III secolo nella Chiesa di Alessandria si osservava il digiuno durante l’intera settimana precedente la Pasqua.
È difficile sostenere la stessa cosa per Roma: si può solo constatare che la domenica e il venerdì prima di Pasqua erano detti De Passione e che il mercoledì e il venerdì della stessa settimana erano giorni aliturgici. Sappiamo poi che nel V secolo viene letto il racconto della passione la domenica, il mercoledì e il venerdì. Entrambi questi dati sono indizi di una prassi molto antica.
La preparazione di tre settimane
Nel corso del IV secolo si organizza la preparazione pasquale di tre settimane. Ciò si può dedurre con grande probabilità dalle seguenti constatazioni:
- La terza domenica prima di Pasqua (escludendo la Pasqua stessa) era detta Dominica in mediana; questa è una denominazione tipicamente romana. Questa settimana era riservata alle Ordinazioni.
- Durante queste tre settimane si proclamava il Vangelo secondo Giovanni: tale fatto è significativo, perché la lettura di Giovanni era caratterizzata da brani riferentesi alla prossimità della Pasqua e alla presenza di Gesù a Gerusalemme.
A livello più esplicito, lo storico Socrate ci informa che nei primi decenni del V secolo a Roma la Pasqua era preceduta da tre settimane di preparazione.
La preparazione di sei settimane
L’allungamento del periodo preparatorio da tre a ei settimane iniziò un po’ prima del 384. Le sei settimane avevano carattere prevalentemente ascetico, per l’introduzione della prassi della riconciliazione dei penitenti il Giovedì Santo, dopo quaranta giorni – da qui il nome di Quadragesima– di preparazione; dà testimonianza di ciò Pietro di Alessandria († 311). I penitenti iniziavano la loro preparazione la prima domenica di queste sei settimane. L’inizio sarà anticipato al mercoledì precedente in epoca più tarda.
Le sei settimane subirono progressivamente importanti modifiche:
Le prime tre settimane
Nelle testimonianze più antiche si nota un uso abbastanza frequente del Vangelo secondo Matteo, che viene letto seguendo grosso modo l’ordine dei capitoli. La lettura dell’epistola è normalmente armonizzata con quella del Vangelo.
A livello dei giorni di celebrazione si possono distinguere tre tappe:
- Inizialmente la celebrazione avviene solo nei giorni di domenica, mercoledì, venerdì e sabato. Le letture della prima settimana erano le seguenti:
- Domenica: Mt 4, 1-11 (il Digiuno di Gesù nel deserto); 2Cor 6, 1-10 (il tempo favorevole).
- Mercoledì: Mt 12, 38-50 (Il segno di Giona, il ritorno offensivo dello spirito immondo, i veri parenti di Gesù); Es 24, 12-18 (il digiuno e i quaranta giorni di Mosè sul Sinai); 1Re 19, 2-8 (il digiuno di quaranta giorni del profeta Elia).
- Venerdì: Gv 5, 1-15 (la guarigione del paralitico alla piscina di Betesda); Ez 18, 20-28 (la responsabilità personale).
- Sabato: Mt 17, 1-9 (la trasfigurazione); 1Ts 5, 14-23 (esortazione a vivere nella prospettiva del ritorno di Cristo, cioè della nostra personale trasfigurazione).
- Viene poi introdotta la celebrazione del lunedì e del martedì. Le letture della prima settimana erano:
- Lunedì: Mt 25, 31-36 (il giudizio universale con il trionfo della carità verso il prossimo); Ez 34, 11-16 (il Signore, Buon Pastore, raduna le sue pecore e le conduce a pascoli verdeggianti).
- Martedì: Mt 21, 10-17 (la cacciata dei venditori dal Tempio); Is 55, 6-11 (i pensieri del Signore non sono quelli dell’uomo).
- Con Gregorio II (715–731) si inizia a celebrare anche il giovedì. Nella prima settimana si legge Mt 15, 21-28 (la fede della cananea) ed Ez 18, 1-9 (la responsabilità personale).
Il prolungamento dei quaranta giorni
Verso la fine del V secolo ha inizio la celebrazione del mercoledì e del venerdì precedenti la Quaresima (che fino ad allora iniziava con la prima domenica) come se ne facessero parte. Si giunse a imporre le ceneri ai penitenti il mercoledì di questa settimana antecedente la prima domenica e tale cerimonia verrà poi estesa a tutti i cristiani, ad eccezione della Chiesa di Rito Ambrosiano che non aderì a questo cambiamento.
Il Sacramentario Gelasiano afferma che i penitenti entrano in un rigido “ritiro spirituale” il Mercoledì delle Ceneri per rimanervi fino al Giovedì Santo e che il Mercoledì delle Ceneri è considerato il caput quadragesimae.
L’impostazione del Vaticano II
In questa linea, la riforma liturgica ha reimpostato la Quaresima:
- ne ha ripristinato l’orientamento pasquale-battesimale;
- ne ha fissato il tempo con la decorrenza dal Mercoledì delle Ceneri fino alla Messa in Coena Domini esclusa, sopprimendo altresì i tempi di settuagesima, sessagesima e quinquagesima;
- ha ridotto il tempo di passione, che, nel Messale di San Pio V, iniziava con la V Domenica di Quaresima, giorno in cui si velavano le croci; ora tale tempo inizia con la Domenica delle Palme de Passione Domini (“dalla Passione del Signore”): la Settimana Santa (nel Rito Ambrosiano è detta Settimana Autentica) conclude così la Quaresima;
Inoltre è stata resa più abbondante la selezione dei testi biblico. Il lezionario delle domeniche offre la possibilità dei tre itinerari:
- una Quaresima battesimale (Anno A);
- una Quaresima cristologica (Anno B);
- una Quaresima penitenziale (Anno C).
I testi dell’Antico Testamento presentano ora in modo particolare la Storia della Salvezza.
Spiritualità
Il senso autentico della Quaresima si coglie nella luce del Mistero Pasquale, che viene celebrato nel solenne Triduo Pasquale e dei Sacramenti dell’Iniziazione Cristiana che in esso hanno la loro più propria collocazione. La Quaresima è quindi l’opportunità di una più viva partecipazione al Mistero di Cristo morto e risorto: “Partecipiamo alle sue sofferenze per partecipare anche alla sua gloria” (Rm 8, 17 ). L’accento non va posto quindi sulle pratiche ascetiche (digiuno e astinenza dalle carni, preghiera e opere di carità), ma sull’azione purificatrice e santificatrice del Signore, che si traduce nel fedele nell’impegno della conversione e del ritorno a Dio: «O Dio, nostro Padre, con la celebrazione di questa Quaresima, segno sacramentale della nostra conversione, concedi a noi tuoi fedeli di crescere nella conoscenza del mistero di Cristo e di testimoniarlo con una degna condotta di vita». (Messale Romano, Colletta della I Domenica di Quaresima, Anno B).
[Fonte: cathopedia.org]

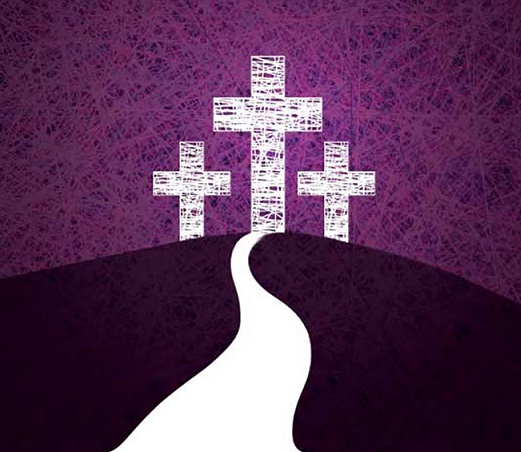


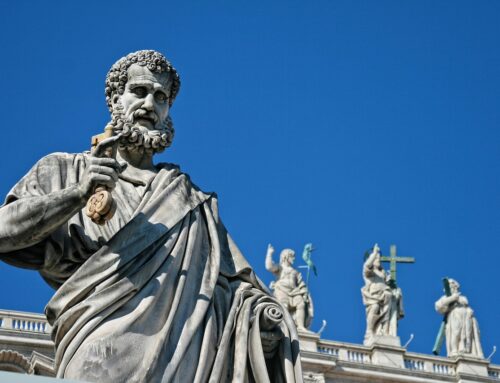

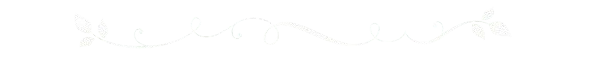
Scrivi un commento